da Baltazzar | Set 16, 2010 | Testimonianze
Intervista a Mino Damato, pochi giorni prima della sua morte
di fra Antonio Scaramuzzi
ROMA, mercoledì, 15 settembre 2010 (ZENIT.org).- E’ morto venerdì 16 luglio, giorno della Madonna Del Carmine, all’età di 73 anni, Mino Damato, popolare giornalista e conduttore tv.
Damato era noto non solo per una brillantissima carriera in ambito televisivo ma soprattutto per il suo impegno nella lotta contro l’Aids e nel campo del volontariato e della solidarietà.
Nel 1995 ha creato la Fondazione Bambini in Emergenza per occuparsi dei bambini abbandonati e malati di Aids, dopo aver adottato una bimba romena ammalata e morta nel 1996 a nove anni.
Pochi giorni prima di morire Damato ha concesso una intervista a ZENIT.
Un giornalista che ha lasciato la televisione per dedicarsi al volontariato e al prossimo. Ci racconti la sua esperienza?
Mino Damato: Una esperienza di 20 anni richiederebbe perlomeno due ore per essere raccontata…diciamo che ho ascoltato le voci di dentro che mi dicevano di andare verso una certa direzione. Non è stata una scelta intervenuta in un giorno, come se accendi la luce, oppure ti alzi e vai missionario. Non è così. E’ cominciata così da piccole cose. Chiaramente come in un matrimonio, a volte. Un matrimonio comincia con un coinvolgimento.
Come si chiama la Fondazione?
Mino Damato: La fondazione si chiama Fondazione Bambini in Emergenza, nel sito in rete www.bambiniinemergenza.org ci sono tutte le indicazioni: cosa facciamo, come siano nati, quali sono gli amici che ci aiutano, noi ci occupiamo esclusivamente di bambini, abbandonati e malati.
Un gesto bello…quale delle tante esperienze che ha fatto con la Fondazione ricorda particolarmente?
Mino Damato: Ogni bambino ha una sua storia, in comune c’è l’abbandono, il trauma che subiscono i bambini più piccoli. I bambini più piccoli capiscono tutto, sanno anche di che cosa hanno bisogno, di una figura maschile, una femminile, che li protegga, li consigli.
Il suo rapporto con padre Pio?
Mino Damato: A casa mia erano e sono devoti, io non ho avuto la fortuna di andare personalmente da padre Pio, preferisco per quello che mi riguarda, pregare davanti ad una sua immagine, ho bisogno di sentire le sintonie, che cosa mi trasmette un luogo, però rimane grande la devozione per padre Pio!
Chi è Gesù Cristo per lei?
Mino Damato: Ha vissuto fino all’ultimo le gioie, ma anche le paure di un uomo di fronte al grande mistero della vita e della morte, il fatto che anche il Padre l’avesse abbandonato in un momento importante che è quello dell’arresto e di quello che poi è seguito…ne fa comunque un uomo, il più grande rivoluzionario nella storia degli uomini, ha gettato le basi per una vita diversa.
Quale messaggio vorrebbe comunicare al mondo del volontariato, a noi impegnati nella Mensa dei Poveri e nelle altre realtà del volontariato della provincia di Foggia?
Mino Damato: Io direi che occorre perdere un minimo, un minimo di protagonismo nel volontariato. Il mio tempo lo passo non in cene e davanti alla televisione; ho costruito una chiesa, potrei dire, non perché ho avuto una visione. Costruire una chiesa vuol dire anche stabilire delle radici per le suore (ci sono le suore francescane missionarie di Assisi che mi aiutano a portare avanti i nostri progetti), che sul posto portano avanti un altro tipo di discorso, molto più bello, molto più profondo. Quello che dobbiamo fare noi è mettere a servizio totale quelle che sono le nostre capacità, e rifugiarci nelle braccia di Gesù grande. Ma soprattutto non chiedere aiuto alla Provvidenza se prima non hai dato fino all’ultima goccia dell’energia che hai dentro.
da Baltazzar | Set 15, 2010 | Chiesa, Testimonianze
Il cardinale inglese e il cammino verso la santità
di Inos Biffi
Tratto da L’Osservatore Romano del 14 settembre 2010
Qualche anno prima che John Henry Newman morisse, il vescovo di Birmingham, nome Ullathorne, dopo averlo incontrato, commentava: “Mi sono sentito rimpicciolito davanti alla sua presenza. Dentro quest’uomo c’è un santo”. Era una persuasione diffusa, riconosciuta persino dal cardinale Manning, che in precedenza non aveva nutrito sentimenti di eccessiva simpatia per Newman, per non dire che, con padre nome Faber, lo aveva fortemente avversato ed era stato – sono parole di Newman – ingiusto verso di lui.
Dichiarava il cardinale nell’elogio funebre: “A nostra memoria, nessun inglese è stato oggetto di una venerazione così viva e sincera. Fu centro di numerose anime, che erano andate da lui, come maestro, guida e consigliere durante molti anni. Una vita bella e nobile”. Lo si potrebbe dire per la sua santità: “bella e nobile” e avvolta dalla discrezione e dal velo del silenzio.
Non troviamo in Newman forme “impressionanti” o manifestazioni eccessive nella sua concezione e nella sua esperienza della vita cristiana, ma un senso vivo e sereno della “misura”, un equilibrio lontano da ogni esasperazione, un innato distacco dalle cose di questo mondo e un chiaro tratto di humour, ora più dolce ora più amaro, che sono probabilmente tra le ragioni della sua simpatia per Filippo Neri e della scelta di essere suo discepolo.
Del fondatore dell’Oratorio egli era, infatti, un ammiratore sconfinato e devotissimo, come rivelano le sue riflessioni e orazioni nella Novena di san Filippo Neri, o le Litanie di san Filippo, che invocava come: “Eroe nascosto”, “Santo amabile”, “Padre soavissimo”, “Cuore di fuoco”, “Luce di gioia santa”.
Per la sua intercessione implorava: “Ottienimi la grazia della perfetta rassegnazione alla volontà di Dio, dell’indifferenza alle cose di questo mondo, e di tenere gli occhi rivolti continuamente al cielo, di modo che io non dispiaccia mai alla divina provvidenza, non mi perda d’animo, non sia mai triste”. E in una sua meditazione chiedeva: “Mio Signore, mio unico Dio, Deus meus et omnia, non permettere che io corra dietro a ciò che è vano. Tutto è ombra e vanità quaggiù – lo reciterà anche la sua epigrafe -. Conserva il mio cuore fragilissimo e la mia anima debole sotto la divina protezione. Attirami a te al mattino, a mezzogiorno e alla sera”.
Si potrebbe dire che la santità di Newman sia stata segnata dalla “raffinatezza”, che, a suo giudizio – come spiegava ai suoi oratoriani -, “mette in evidenza e rende attraente la santità interiore, allo stesso modo in cui il dono dell’eloquenza esalta il ragionamento logico”.
Ma nobiltà e raffinatezza della santità non significano facilità o assenza di difficoltà. Newman, come ogni discepolo del Signore, ha percorso, infatti, un cammino disseminato di difficoltà e segnato da svolte fondamentali e dolorose di “conversione”.
Vi era anzitutto il suo temperamento. Egli doveva purificare un’ipersensibilità facilmente vulnerabile e appuntita, una suscettibilità facile a offendersi, una “fermezza d’acciaio” (Bouyer) penetrante, inclinata a reagire con pungente ironia, oltre al difetto comune agli intellettuali di un eccessivo gusto per la sottile discussione.
E qui possiamo osservare che non esistono temperamenti avvantaggiati o svantaggiati nei confronti della santità, ma una chiamata identica per tutti a trasformare la natura con l’ausilio della grazia, e viene in mente quanto lo stesso Newman diceva di Cirillo d’Alessandria: “Cirillo, lo so, è un santo; ma non vuol dire che fosse un santo nel 412. Fra i più grandi santi si trovano anche quelli che nella prima parte della vita hanno commesso delle azioni tutt’altro che sante. Non penso che a Cirillo possa piacere che i suoi atti storici siano presi a misura della sua santità interiore”.
Quanto alle tappe del cammino di Newman alla santità – in ogni caso immediatamente sono aperte solo allo sguardo infallibile di Dio – possiamo discernere come prima quella del “grande rivolgimento di pensieri” che lo toccò, quindicenne, nell’autunno del 1816. Egli fu allora pervaso dall’evidenza luminosa, che non si spegnerà più, di “due e solo due esseri assoluti”, il suo “io” e il suo “Creatore”, il quale “gli si impose, in modo intimo, senza intermediari”, non come un’idea astratta, ma nella consistenza di un Essere vivo, così come fatti vivi erano per lui i misteri della fede o i grandi dogmi quali la Trinità, l’incarnazione, la redenzione. Sempre nel tempo della sua prima conversione, lo aveva colpito un’espressione di Walter Scott, che divenne un programma: “La santità più che la pace”.
Un’altra tappa decisiva nell’itinerario spirituale di Newman fu il superamento del liberalismo che incominciava a fargli preferire “l’eccellenza intellettuale a quella morale” e furono provvidenziali il viaggio nel Mediterraneo, la malattia in Sicilia, la scoperta del suo orgoglio, l’implorazione della Luce e il proposito di camminare sotto la sua guida. La santità di Newman appare come il crescere perseverante e senza strepito della puntuale corrispondenza a questa Luce.
Poi venne la “conversione” alla Chiesa cattolica, dove, con tutto lo strazio del distacco dall’antica Chiesa, dagli amici e dai familiari, risalta la fedeltà eroica alla coscienza e insieme alla volontà di Dio che in essa vedeva riflessa.
Ma proprio dopo questa conversione incomincia “la sua così lunga e spesso penosa vita”, lungo la quale non sarebbero mancate situazioni difficili e profondi motivi di sofferenza, di fronte a chiari segni di sfiducia, a manovre non limpide, ad anni di emarginazione e di isolamento.
Possiamo seguire queste prove particolarmente negli Scritti autobiografici. Nel 1860 constatava e scriveva nel suo diario: “Non ho nessun amico a Roma, ho lavorato in Inghilterra dove non sono stato capito e dove mi hanno attaccato e disprezzato. Pare che sia incorso in molti fallimenti”, e aggiungerà: “Credo di dire tutto questo senza amarezza”. E ancora annotava: “Quanto è stata triste e solitaria la mia vita da quando sono diventato cattolico (…), da quando ho fatto il grande sacrificio al quale Dio mi chiamava. Egli mi ha compensato in mille modi, e tanto largamente. Ma ha segnato il mio cammino di mortificazioni quasi ininterrotte. La sua volontà benedetta non mi ha accordato molto successo nella vita. Da quando sono cattolico mi sembra di non aver avuto che degli insuccessi personali”.
E aggiungeva nel gennaio del 1863 – Newman aveva 62 anni -: “Non mi stupisco delle prove, che sono il nostro retaggio quaggiù; ciò che mi amareggia è che, per quanto possa vedere, ho fatto così poco, in mezzo a tutte queste mie prove. La mia vita è stata triste perché, se guardo indietro, essa è stata un gran fallimento”. Nel 1867, riconoscendo il lungo tempo in cui il Signore lo aveva abbandonato alla dimenticanza e alla calunnia, annotava: “Mi metterò sotto l’immagine del patriarca Giobbe, senza la pretesa di paragonarmi a lui”, ma aggiungeva, sentendosi distaccato da tutto: “Ora sono in uno stato di quiete. Niente di quello che mi è capitato impedisce la mia gioia interiore, o piuttosto queste vicissitudini esteriori vi hanno magnificamente contribuito”; e due anni dopo riconosceva: “La Provvidenza di Dio è stata mirabile verso di me attraverso tutta la mia vita”.
La santità di Newman è maturata in modo particolare per la fede, la speranza e la carità con cui egli ha saputo a lungo e pazientemente accogliere questa forma di croce, tanto più dolorosa quanto più viva era la sensibilità del suo animo e il suo amore per la verità e la giustizia.
Ma non solo leggendo il suo Diario, noi possiamo avvertire la sua passione per la santità: tutti i suoi scritti, anche quelli più teoretici, rivelano con trasparenza questo anelito. Pensiamo ai suoi pacati e tersi Sermoni Parrocchiali – in cui si ritrova tutto il suo ininterrotto ascolto della Parola di Dio -, alle composizioni liriche, in cui si fondono santità e poesia, alle Meditazioni e Preghiere, e a quegli avvincenti profili dei Padri, la cui compagnia lo affascinava.
Bremond osserva che Newman sceglieva i Padri anzitutto come amici: amici santi, così che le ore dedicate ad essi fossero “una specie di preghiera”. E lo si avverte subito: l’intimità con Basilio, Gregorio di Nazianzo, Crisostomo, Agostino, e altri ancora, erano una scuola concreta e intensa di santità, ed effettivamente concorrevano a crearla in chi ne ricostruiva le peripezie e ne condivideva la vita interiore. Diceva sempre Bremond: “Chi non ama la santità, non ama i santi”.
Newman mostra di amare sia i santi sia la santità.
da Baltazzar | Set 13, 2010 | Cultura e Società, Testimonianze
«Il suo argomentare è così puro che finisce per essere rivoluzionario anche nella forma. È impossibile prevedere dove andrà a parare. Assorbito dalle verità che vuol penetrare, sviluppa i ragionamenti con totale disinvoltura e libertà, in apparenza incurante dei seguiti sul piano morale»
di Muriel Spark
Tratto da Avvenire del 12 settembre 2010
Negli ultimi 12 anni, nei momenti in cui sentivo che la mia mente era congestionata dalle troppe voci che ascoltava, inclusa la mia, mi sono rivolta ai sermoni pronunciati da John Henry Newman di fronte agli studenti di Oxford quand’era parroco della chiesa di St. Mary. A detta di tutti, la sua voce dal pulpito possedeva un fascino veramente speciale. Sono sicura che, da centovent’anni a questa parte, nulla di tale fascino sia andato perduto e anzi che, col passar del tempo, esso sia ulteriormente cresciuto: infatti, se c’è un tratto comune che emerge dagli scritti di Newman è che hanno tutti una «voce», una voce che è sua e di nessun altro. E, perlomeno per me, questa voce non manca mai di risuonare con eccezionale intensità dalle sue pagine, per quanto vecchio e ammuffito sia il libro che le contiene.
Se posso evitarlo, non leggo mai un libro solo per cercarvi informazioni. Non mi piacciono le opere destinate all’edificazione spirituale a meno che non siano ben scritte. Non toccherei neppure la Bibbia se, al di là dei suoi aspetti contenutistici, non fosse interessante anche sotto il profilo storico, letterario e per molti altri versi. Leggo i sermoni di Newman perché sono di Newman, non perché sono sermoni. Egli è limpido come l’acqua.
«Ogni mio pensiero – afferma – è solo quel pensiero, e ogni mia parola è solo quella parola». Il suo modo di argomentare è così puro che finisce per essere rivoluzionario anche nella forma.
Egli non segue un percorso logico lineare, ma prevalentemente interiore, che lo conduce a esplorare i più reconditi recessi dei temi che affronta.
Con Newman è impossibile prevedere dove andrà a parare. Interamente assorbito dalle verità che si sforza di penetrare, egli sviluppa i suoi ragionamenti con totale disinvoltura e libertà, senza preoccuparsi della piega che sembrano prendere sul piano morale. Egli è fermamente determinato a cogliere, grazie a un’accurata introspezione psicologica, il nucleo etico di ogni argomento, riuscendoci in pieno.
Come esempio di tale procedimento propongo il sermone «Obbedienza senza amore»: l’esempio di Balaam, perché ritengo illustri non solo i suoi tipici schemi mentali ed espressivi, ma anche, e in modo più evidente di ogni altro, il tema dell’amore di Dio, che a mio avviso può essere definito il motivo centrale della riflessione di Newman. E all’investigazione di questo tema è esplicitamente dedicato il suo sermone su Balaam, il quale, egli sottolinea, «era un uomo di nobili principi, onorato e coscienzioso […]. Non si limitava a parlare di religione, ma obbediva ai suoi precetti; stando così le cose, percepiremo ancor più intimamente il valore dei nobili sentimenti che di tanto in tanto si lasciava sfuggire di bocca e che, se egli si fosse dimostrato meno fermo nella sua condotta, avrebbero potuto passare per semplici parole, le parole di un abile confezionatore di discorsi, un sofista, un moralista o un retore, come quando dice: ‘Possa io morire della morte dei giusti, e sia la mia fine come la loro’». Non è un ritratto ironico. Balaam – prosegue l’autore – era un autentico prodigio di grazia, rettitudine e pietà, al quale mancava soltanto l’ingrediente essenziale per la piena fioritura della sua anima: l’amore di Dio. Newman era convinto che i suoi connazionali fraintendessero enormemente la natura divina quando davano per scontato che il Signore approvasse gli standard esteriori che loro avevano approvato.
All’epoca di Newman, infatti, vi era un importante movimento moraleggiante, ma anche ai giorni nostri vi è una forte rivendicazione moralistica, e il peggio deve ancora venire: prima o poi spunteranno ovunque cittadini etici e «asettici», destinati a una sempre maggiore prosperità e visibilità, in segno di pubblico riconoscimento per le loro virtù. A tale proposito, Newman afferma: «Ma per chi si fa guidare dalla Scrittura è del tutto evidente che anche l’uomo più coscienzioso, devoto, onorato e di nobili principi (uso questi termini nella loro accezione comune, non in quella scritturale) può trovarsi dalla parte del male, può essere uno strumento di Satana per maledire – ove ciò fosse possibile –, o quantomeno sedurre e indebolire, il popolo di Dio». Il famoso grido scandalizzato di Charles Kingsley: «Ma allora che cosa intende il dottor Newman?», era tipico dei moralisti cristiani dell’epoca. Appartiene all’insegnamento dottrinale di tutte le confessioni cristiane il principio per cui, senza la carità, siamo come un bronzo che risuona e un cembalo che tintinna. Ma Newman mette in luce alcune delle allarmanti implicazioni di questo poetico versetto. Che cosa intende? Che Dio non ha studiato a Rugby: ecco, più o meno, che cosa intende. Le persone serie invocano tuttora, di tanto in tanto, un «ritorno agli standard etici del cristianesimo», alludendo a quei codici di rispettabilità che sono sorti nell’Occidente cavalleresco dalla fede cristiana. Molti ritengono che sia la morale ciò che conta; il cristianesimo può anche sparire. Io non sono un’esperta in materia, ma percepisco sempre, sotto queste rivendicazioni e pressioni di stampo moralistico, un bisogno di mettersi in mostra.
Mostriamo agli altri – dicono costoro – cos’è lo spirito di servizio; riscopriamo l’austerità, lavoriamo sodo, ripuliamo le nostre strade; la moralità non dev’essere solo essere messa in pratica, dev’essere anche vista; torniamo all’ipocrisia dei nostri antenati: a Dio piaceva così tanto quando tutti andavano in chiesa e non commettevano adulterio! Il peculiare contributo di Newman a quest’ambito di studio consiste nell’affermare che perfino le persone coscienziose e di nobili principi morali possono trovarsi dalla parte del male. Egli sostiene che, per quanto ispirate e onorevoli siano, esse possono essere strumenti di Satana per sedurre e indebolire il popolo di Dio. Inoltre, soltanto Dio sa chi è realmente gradito ai suoi occhi. Il vero orientamento di ogni anima è un segreto non facile da discernere.
da Baltazzar | Set 6, 2010 | Chiesa sofferente, Testimonianze
L’arcivescovo Bader parla della difficile testimonianza dei fedeli in Algeria
Tratto da L’Osservatore Romano del 5 settembre 2010
“Un cristiano in mezzo ai musulmani cambia molte cose. Dà l’esempio di qualcosa di diverso. La nostra amicizia, il nostro spirito di servizio, fanno sorgere delle domande nei nostri compatrioti musulmani, del tipo: “Perché i cristiani si comportano così? Perché vivono in mezzo a noi nonostante siano minacciati?””.
In un’intervista all’Opera di diritto pontificio “Aiuto alla Chiesa che Soffre”, l’arcivescovo di Algeri, Ghaleb Moussa Abdalla Bader, spiega che, nonostante rappresentino solo una piccola minoranza, i cattolici in Algeria svolgono un importante compito, quello di testimoniare Cristo e di dare corpo alla sua Chiesa. E che, al di là delle difficoltà nei rapporti con le autorità, i cristiani sono apprezzati dalla gente.
Come a Tibhirine (ottanta chilometri a sud-est di Algeri), teatro nel 1996 del rapimento e dell’uccisione da parte di terroristi di sette monaci trappisti, tra cui Christian de Chergé, priore del monastero cistercense di Notre-Dame de l’Atlas. Il monastero da allora è deserto, utilizzato solo per gli esercizi spirituali e altri incontri, “ma gli abitanti – ricorda monsignor Bader – seguitano a domandarmi quando torneranno altri monaci. Semplicemente ne sentono la mancanza”. In Algeria i cristiani rappresentano una piccola minoranza. Secondo alcune stime, ci sarebbero solo diecimila protestanti e cinquemila cattolici. Dal 2006 la legge che punisce ogni forma di evangelizzazione, e che riguarda soprattutto la diffusione di testi religiosi, mezzi audiovisivi e qualunque altra iniziativa che “possa minare la fede di un musulmano”, ha di fatto limitato la libertà religiosa dei cristiani nel Paese. Un decreto elaborato, secondo alcuni, per reagire al fenomeno della conversione di numerosi musulmani al cristianesimo, soprattutto attraverso l’avvicinamento ai movimenti evangelici. Da allora gli incontri sono monitorati, sono vietate le pratiche religiose pubbliche e restrizioni sono state poste alle donazioni provenienti dall’estero.
Monsignor Bader, da quando, poco più di due anni fa, è stato consacrato arcivescovo di Algeri, non ha cessato di chiedere alle autorità garanzie affinché ai cristiani sia riconosciuto il diritto alla libertà di professare la propria fede. Ma non è l’unico disagio: “La Chiesa – sottolinea – ha bisogno di sacerdoti, religiosi e religiose che si dichiarino pronti a prendere sulle loro spalle i molteplici compiti pastorali. Mancano collaboratori per i servizi sanitari e occorre organizzare corsi specifici per la formazione delle donne”.
da Baltazzar | Set 6, 2010 | Cultura e Società, Testimonianze
di Vincenzo Andraous
Tra un morto ammazzato e un carcere costretto a vivere del suo, ecco che un paio di detenuti hanno pensato bene di levare le tende, darsela a gambe.
Un’evasione da non poter essere neppure raccontata, perché privata in partenza di ogni letteratura, di qualsivoglia vanteria criminale. Se ne sono andati dentro un vero e proprio tradimento culturale, volgendo le spalle a quel patto di lealtà, stipulato innanzitutto con se stessi, con le Istituzioni, con la gente all’intorno, ristretta e libera.
Un’evasione messa in atto da persone di scarsa pericolosità sociale, a bassa soglia di attenzione, un’evasione accaduta non per mancanza di personale, ma perché a metterla in scena sono stati “ quelli dalla faccia voltata indietro” per dirla alla Adriano Sofri, uomini destinati a varcare nuovamente il cancello blindato di un penitenziario, perché in quei passi affrettati verso una libertà prostituta ci sono le certezze inconfessabili per un ritorno a breve termine nelle patrie galere.
Lo hanno fatto non da un istituto additato a fortino della disumanità, no, hanno scardinato la propria dignità da un luogo fortemente deputato a svolgere il ruolo di recupero del condannato, la propria utilità sociale sul versante della giusta pena da scontare e della conseguente riparazione da mettere in pratica.
Tanti anni fa anch’io ho usufruito di questa opportunità, dentro un progetto di destrutturazione e ricostruzione interiore, ho avuto la possibilità di ritornare a essere una persona migliore. Conosco bene la metodologia del lavoro esterno in e fuori dal carcere, e come rientrando nei requisiti previsti, sia possibile (per pochi), accedere all’istituto dell’ art. 21, come questa eventuale concessione implichi il mettere in gioco la propria autorevolezza e il proprio prestigio per la Direzione del carcere.
Per arrivare a questo obiettivo, non è sufficiente la mera buona condotta, non è un beneficio strettamente imparentato con una sorta di automatismo. Avevo trascorso oltre venti anni di carcere, non mi erano mai stati concessi permessi premio, l’art. 21 è tutto incentrato sullo strumento principe per ogni trattamento rieducativo: il lavoro e la dignità che ne deriva.
In quella “evasione” non c’entrano né pesano le problematiche endemiche dell’Amministrazione Penitenziaria: il sovraffollamento, la carenza di personale, l’assenza di investimenti finanziari appropriati.
Il detenuto ammesso al lavoro esterno è una persona che gode di fiducia, capace di affidabilità, protagonista di un percorso di risalita esistenziale, di un cambiamento di mentalità.
Avrei potuto anch’io alzare i tacchi, “evadere”, ma quando non si ha più residenzialità con il proprio passato criminale, con la pericolosità sociale, il cammino in atto non è più strettamente legato al solo contenimento, alla sola incapacitazione, bensì è sinonimo di collaborazione lavorativa e di risvolti umani condivisi.
Potevo incamminarmi verso l’uscita, verso la rete metallica, verso una libertà miserabile, ma non mi è mai sfiorata l’idea di ritornare a una vita sottobanco, per anni ho usufruito del lavoro interno-esterno alla prigione, soprattutto di una piccola ma grande manutenzione dell’anima, e ogni giorno che scorre via, comprendo il valore delle responsabilità acquisite che fanno la distanza da “quelli dalla faccia voltata indietro”.
da Baltazzar | Set 3, 2010 | Cultura e Società, Testimonianze
di Silvia Guidi
“Non c’è niente di più trasgressivo ed eccitante dell’ortodossia” scriveva Chesterton, con il suo inguaribile amore per il paradosso urticante, volutamente fastidioso, l’unica risorsa dialettica ancora capace di épater le bourgeois del nichilismo gaio di cui l’apologeta inglese nei primi decenni del Novecento cominciava a vedere le prime avvisaglie.
Nina Hagen, storica icona rock amata da Wim Wenders e Pedro Almodóvar, da due anni a questa parte ha scoperto che è proprio così, che Chesterton aveva ragione: di nichilismo non è facile vivere e di nichilismo, in molti casi, si può morire. L’ha scoperto senza rinnegare niente della sua storia, portando alle estreme conseguenze la lotta contro il perbenismo sonnolento e compiaciuto di sé che tanti anni prima, ragazzina della ex Ddr prima della caduta del Muro, le aveva dato lo slancio e la grinta per gridare su un palco tutta la sua ribellione, incoraggiata dal cantautore dissidente Wolf Biermann.
Biermann, compagno di sua madre, la invitava a non lasciarsi mai omologare e plasmare dagli automatismi della mentalità dominante; in quegli anni per Nina la contestazione punk coincideva con l’affermazione della propria irripetibile unicità contro tutto e tutti e la determinazione a non farsi schiacciare dai diktat etici ed estetici del pensiero unico condiviso, voluto e imposto capillarmente dal potere economico, politico, culturale provvisoriamente egemone. Con la musica rock e un’ironia corrosiva come alleate nella costante tensione a smantellare ogni ipocrisia e svuotare i riti sociali della loro parvenza di necessità immutabile, Nina sentiva di poter vincere, da sola, la sua sfida contro il mondo. 
Ma il tempo, “grande scultore” secondo la bella definizione della Yourcenar, proprio mentre le stava regalando successo, fama, popolarità, insieme alla stima e all’affetto di tanti amici, scalpellava via, anno dopo anno, scorciatoie illusorie, false partenze e soluzioni apparenti, svelando l’impotenza ultima di ogni anelito autarchico e anarchico alla liberazione dell’io. Se non alimentata dall’esterno, presto o tardi anche l’originalità artistica più brillante diventa caricatura di se stessa, monologo autoreferenziale, narcisista e sterile “moda”. E la moda, come scrive Leopardi nelle sue Operette morali, è sorella della morte; entrambe nascono dalla caducità. Lo sperimenta anche Nina.
Alla gioia di comunicare se stessi cantando dal vivo davanti a migliaia di fan si affiancano presto i tributi alla liturgia del circo Barnum del rock e le leggi non scritte dello show business. Il “personaggio” rocker è costretto a rilanciare ogni volta la posta della sua popolarità se vuole sopravvivere, inciampando nello sberleffo gratuito e nella spacconeria banale. Il grido autentico espresso dalla musica si perde in goliardate adolescenziali di dubbio gusto, la ribellione contro l’Apparato, il Palazzo, o il Potere in genere diventa ribellismo di maniera, vacuo quando non autodistruttivo, nel migliore dei casi astratto e fuori dalla storia.
La maschera, presto o tardi, soffoca il viso e lo rende uguale a quello di mille altri; il desiderio di eternità che vibra nello slogan Punk never die sbiadisce sui muri come i colori di un graffito di periferia o la scritta di un ragazzino su un banco di scuola, fino a confluire in un conformismo ribellista ancora più insidioso del perbenismo formale che si voleva combattere.
Chi o che cosa è capace di tutelare la libertà espressiva e la “vita autentica” del singolo, se non siamo capaci nemmeno di tutelare noi stessi? Se l’uomo non riesce a salvarsi da solo, chi o che cosa può farlo? È a questo punto che diventa decisivo l’incontro con l’Uomo più genialmente anticonformista della storia, il “Rivoluzionario divino” disposto a dare la vita per permettere agli uomini di vivere pienamente e per sempre.
Battuta e conquistata sul suo stesso terreno, l’anima barricadera di Nina si arrende, accetta di lasciarsi raggiungere da questo nuovo, antichissimo, tenace Amore che da anni la insegue e le tende continui tranelli affettivi. Dio – spiega la Hagen – l’ha raggiunta attraverso la gioia di amare ed essere amata, il miracolo costante dell’amicizia, il dono della maternità ricevuto con i figli Cosma e Otis, la felicità di dare senza risparmio tempo, cura e tenerezza a due piccoli esseri totalmente indifesi che nei loro primi giorni di vita possono ricambiare solo con pianti interminabili, misteriosi mal di pancia in piena notte e sorrisi sdentati.
Dio fatto uomo e presente nella storia le ha teso continue imboscate artistiche e professionali, attirandola a sé con il dono di una voce che si arrampica agevolmente sulle difficoltà tecniche più impervie e con la profonda, intensa commozione che le comunica da sempre la musica gospel.
Guardando con lealtà la sua esperienza, frutto di mezzo secolo di vita, Nina si è accorta che il Dio fatto uomo, il “suo” Personal Jesus (il titolo del nuovo album che uscirà in Italia a settembre) la corteggia da sempre con le modalità più fantasiose, impreviste e rispettose della sua libertà, e da sempre, con infinita pazienza, la invita a un dialogo personale con Lui.
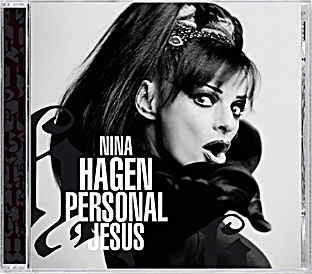 “Non ho nessun nuovo stile – spiega la Hagen a Giancarlo Riccio, il giornalista de “L’Espresso” che l’ha raggiunta qualche giorno fa a Berlino per capire se la sua conversione è una trovata pubblicitaria o meno – Io sono musicista e cantante e ho abbracciato le radici del gospel americano delle origini e la musica rock per tutta la vita. Riascolti i miei dischi quando avevo 18 anni: ci troverà già molte canzoni gospel, come ad esempio i Mahalia Jackson-Hits, Right on Time, Gonna Live the Life, Hold me… Ave Maria, Spirit in the Sky“.
“Non ho nessun nuovo stile – spiega la Hagen a Giancarlo Riccio, il giornalista de “L’Espresso” che l’ha raggiunta qualche giorno fa a Berlino per capire se la sua conversione è una trovata pubblicitaria o meno – Io sono musicista e cantante e ho abbracciato le radici del gospel americano delle origini e la musica rock per tutta la vita. Riascolti i miei dischi quando avevo 18 anni: ci troverà già molte canzoni gospel, come ad esempio i Mahalia Jackson-Hits, Right on Time, Gonna Live the Life, Hold me… Ave Maria, Spirit in the Sky“.
È sempre la stessa, Nina, ma negli anni il generico rispetto, venato di indifferenza, per il Figlio di Dio è diventato progressivamente un dialogo serrato, intimo, personale. Expertus potest credere quid sit Iesum diligere si legge in un antico inno della tradizione cristiana: tenerezza, protezione, amore incondizionato, paziente e concretissimo, capacità di un perdono che rigenera e ricava “acqua pura con l’acqua sporca – come scrive Péguy – acqua giovane dall’acqua vecchia, anime chiare da anime torbide” una trasformazione impossibile all’uomo, segno inequivocabile del Divino.
A 55 anni, Nina scopre che c’è un modo molto semplice per non aver paura del tempo che passa: diventare amici del Padrone del tempo e della storia. Per questo nel suo sito internet ufficiale, accanto alla foto di scena in parrucca blu elettrico e occhi bistrati, in cui fa il verso alla Sally Bowles di Liza Minnelli in Cabaret, ha voluto inserire un santino da prima comunione, con una elegante grafica in stile liberty inizi del Novecento, e una citazione dal salmo 18 “Ti siano gradite le parole della mia bocca/ davanti a te i pensieri del mio cuore/ Signore, mia roccia e mio redentore”. Per fare outing, come va di moda dire adesso, e ribadire che il nuovo album è “un desiderio del cuore, una preghiera del cuore che si è realizzata”.
La Hagen non potrebbe essere più esplicita: “Questo disco è un omaggio al mio Creatore, all’autore della mia vita Gesù Cristo e a tutti gli uomini”. “Ognuno ha bisogno di un Personal Jesus?” le chiede Giancarlo Riccio. “Sì; è costruire giorno per giorno un rapporto personale con il nostro Creatore”. Nina rilancia, insiste, ci tiene a ribadire il concetto: l’incontro personale con Gesù è stato il più grande successo della sua vita. “Lei è anche attrice e performer. In quale parte del mondo ha raggiunto il successo maggiore?” chiede il giornalista. “Nella patria dell’anima. Non è un luogo geografico”. “Insiste nel dire che ama Dio. Perché lo ama?” continua il giornalista de “L’Espresso”. “Perché lo conosco – ripete la Hagen – Dio si è continuamente manifestato nella mia vita. Io sono sua figlia e lo sarò per sempre; è stato Lui che mi ha amato per primo”.
(©L’Osservatore Romano – 3 settembre 2010)

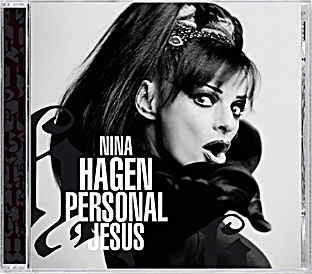 “Non ho nessun nuovo stile – spiega la Hagen a Giancarlo Riccio, il giornalista de “L’Espresso” che l’ha raggiunta qualche giorno fa a Berlino per capire se la sua conversione è una trovata pubblicitaria o meno – Io sono musicista e cantante e ho abbracciato le radici del gospel americano delle origini e la musica rock per tutta la vita. Riascolti i miei dischi quando avevo 18 anni: ci troverà già molte canzoni gospel, come ad esempio i Mahalia Jackson-Hits, Right on Time, Gonna Live the Life, Hold me… Ave Maria, Spirit in the Sky“.
“Non ho nessun nuovo stile – spiega la Hagen a Giancarlo Riccio, il giornalista de “L’Espresso” che l’ha raggiunta qualche giorno fa a Berlino per capire se la sua conversione è una trovata pubblicitaria o meno – Io sono musicista e cantante e ho abbracciato le radici del gospel americano delle origini e la musica rock per tutta la vita. Riascolti i miei dischi quando avevo 18 anni: ci troverà già molte canzoni gospel, come ad esempio i Mahalia Jackson-Hits, Right on Time, Gonna Live the Life, Hold me… Ave Maria, Spirit in the Sky“.